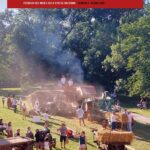 “Dal CONTADO” periodico del Museo della Civiltà Contadina
“Dal CONTADO” periodico del Museo della Civiltà Contadina
Articolo di Daniele Seragnoli “Il profumo della terra, il sapore della storia”
La mostra “Carlo Tassi, Elegia degli affetti: Dipinti, disegni e sculture (1947-2011)”, al Museo della Civiltà Contadina di Villa Smeraldi a Bentivoglio
Curata da Valeria Tassinari e da Mara Vincenzi Tassi, in collaborazione con l’Istituzione Villa Smeraldi, l’esposizione presenta una trentina di lavori di pittura, scultura e grafica di Carlo Tassi (1933-2011), provenienti dalla sua Casa Museo a Bondeno e ospitate in diverse stanze e sezioni della Villa, facendoli dialogare felicemente con gli arredi, gli oggetti e le atmosfere dell’allestimento museale. Una iniziativa, leggiamo nel pieghevole della mostra che “si inserisce nella pluralità di azioni di valorizzazione, salvaguardia e promozione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia, della cultura, delle arti, della politica, della scienza e della spiritualità, progetto regionale denominato Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna”. Un circuito, questo, al quale a buon diritto appartiene la Casa/atelier scelta come ultima dimora da Carlo Tassi alla metà degli anni Novanta del secolo scorso.
Percorrendo i vari spazi del Museo della Civiltà Contadina e osservando le opere dell’artista, collocate sapientemente a volte in maniera “nascosta” con un implicito invito alla scoperta da parte del visitatore, è possibile quasi percepire antichi profumi e sapori proprio di quella civiltà contadina che le opere dell’artista fanno emergere: la vecchia cucina con il suo focolare e i suoi attrezzi, la lavorazione della canapa, la terra e le sue coltivazioni…
Ovunque volgi lo sguardo ti ritrovi immerso in quelle situazioni e in quei climi non in maniera falsamente nostalgica, ma come invito a uno sguardo diverso per vedere diversamente noi stessi al cospetto della Storia collettiva e della nostra e intima storia, oggi.
“Elegia degli affetti”, il titolo intelligentemente scelto per l’esposizione, esplicitando in tal modo vita, poetica, ricerca, relazioni con uomini e donne, paesaggio, che hanno connotato la figura di Carlo Tassi. Uno spazio, quello di Villa Smeraldi, in cui come scrive la curatrice Valeria Tassinari, “piccoli attrezzi e rustiche ambientazioni entrano in stretta relazione con le figure o gli scenari di cui le opere di Tassi custodiscono la memoria, quasi fossero dei ‘ritornanti’ nei luoghi dove un tempo furono presenti. Volti di donne e uomini anziani segnati dal tempo, delicati profili infantili, abbracci materni, fatiche del lavoro, incanti delle stagioni che ruotano caparbiamente nel dialogo infinito tra luna e sole: un mondo narrato con poche parole, chiare eppure sempre magiche, raccolte tra l’intimità delle cucine e la socialità delle osterie, trovate dentro la nebbia, che confonde persino i confini del tempo, o respirate nell’estate che infiamma i campi di papaveri”.
Incontriamo, tra le altre, opere emblematiche come l’olio su carta, Contadini al lavoro nei campi del 1956, o La lavorazione della canapa, uno straordinario olio del 1962 che ben fa pendant con una foto di inizio ‘900, Macerazione della canapa esposta nel Museo della Civiltà Contadina. Richiamando anche antiche immagini guerciniane e intense pagine letterarie di Riccardo Bacchelli (nulla cambia nei secoli a testimoniare la perseveranza del lavoro manuale). O ancora, altra solida traccia di lavoro e di fatica, il bronzo Mia madre Valmen, del 1955, raffigurata in veste di contadina nell’atto di tagliare un mannello di canapa o un fascio di spighe di grano. La ritrovi lì Valmen, insieme alla fusione in bronzo della piccola nipote Cinzia con bambola, un tuttotondo a grandezza naturale dell’anno successivo, insieme a tutti gli altri lavori di Tassi che anche se hai già visto presso la Casa Museo di Bondeno, qui appaiono eccezionalmente “nuovi” e diversi. Non solo perché, è il caso delle opere di pittura e grafica, le vedi da vicino ad altezza di occhi, ma per l’inedita luce che emana in questa non convenzionale esposizione, come solo sanno e possono essere le stanze di un Museo della Civiltà Contadina e non una asettica Galleria d’arte. Qui c’è vita, emozione, sentimento, là soprattutto ragione, critica, intelletto, se non intellettualismo. Difficile coniugare, spesso, le diverse componenti.
Rivelatori gli appellativi che la curatrice ha dato ai diversi locali che ospitano l’arte di Tassi.
Echi di ritorni per la cucina, dove vediamo in particolare disegni: volti di anziane e anziani, una maternità, tra gli altri, “ponti per la memoria e per il cuore” – scrive Valeria Tassinari nel foglio di sala – in un ambiente domestico “tanto evocativo della vita di un tempo che pare ancora di sentirvi i passi, gli odori, i respiri”, che ben si integrano con disegni che “appaiono davvero memorie di vite riportate ai nostri occhi, nel pensiero e nei cuori”.
Canzoni campestri, il titolo dato alla sala della canapa, una dimensione paesaggistica e di lavoro, una socialità che si palesa come spirito autentico della civiltà contadina, un mondo di cui l’artista bondenese “è stato cantore” cogliendo “la bellezza dei grandi maceri, quasi astratti, con le stoppie che spuntano dall’acqua specchiante; il ritmo delle schiene e delle braccia dei lavoratori e delle lavoratrici, curve all’unisono come in una danza; la delicatezza delle dita che filano, infine quella pianta ispida e resistente che, trasformata in filo, sarà intrecciata in stoffe da ripiegare e profumare con cura nei bauli nuziali, preparata ad avvolgere i corpi in tutti i momenti della vita”.
Il salone della Villa, al primo piano, con le Figure del tempo immoto, che accoglie alcune delle opere maggiormente distintive della poetica di Carlo Tassi, come le due terrecotte La seminatrice e Maternità entrambe del’56, e il giovanile Arrotino, marmo bianco di Carrara del 1947, oltre ai bronzi sopra ricordati; i paradigmatici e “scenografici” pensionati all’osteria o impegnati in partite a carte, tre dipinti a olio che spaziano dal 1965 al ’97. Lavori che attestano “la vocazione di Carlo Tassi alla narrazione di storie collettive. Storie che qui non sapremo mai, ma che sappiamo di poter ancora trovare, laddove le persone continuano a incontrarsi, e a darsi reciprocamente il tempo di stare insieme”. Insieme alla “essenzialità sintetica” della scultura, corpi e volti “mossi in superficie da una particolare sensibilità alla luce”.
Il Tempo delle stagioni, nella sala del camino sempre al primo piano, con dipinti degli anni Settanta e Ottanta dove alberi, case, acque, fiori sono per l’artista “memoria del lavoro e della vita semplice”: “quasi provocatoriamente il tempo ciclico delle stagioni ripete come un mantra una poesia inattuale e spirituale, che si rincorre nel sottile incanto del quotidiano come un conforto, cercando nel tempo immoto una possibile rassicurazione contro il cambiamento in atto”.
È un giorno festivo: 21 aprile, Pasquetta, si avvicina il 25, 80° anniversario della Liberazione. Sui prati e negli spazi tutto attorno alla Villa c’è gente che fa il picnic, frotte di bambini che giocano, c’è il profumo degli gnocchi fritti che si effonde da una bancarella, ci sono i galli e la mamma chioccia col pulcino (mascotte e icona del Museo) che girano liberamente accettando volentieri qualche briciola dalle persone che li ammirano e fotografano, senti la musica “alla Filuzzi” eseguita dal vivo e vedi molte coppie che nella pista da ballo volteggiano al ritmo di valzer, mazurke e polke, anziani ancora in forma (e li invidi un po’) e giovani (che ammiri, per il loro essere lì, per il loro accettare l’invito che il Tempo e la Storia gli offre in questo luogo di Memoria assoluta).
Fai ritorno negli spazi interni e la Storia la scopri davvero, grazie ancora a Carlo Tassi. Sì, perché la mostra non espone solo opere di “atmosfera” e di “ambiente”, ma è stata volutamente progettata in corrispondenza proprio con le manifestazioni per gli 80 anni dalla Liberazione dal nazifascismo. E qui emerge la personalità “politica” del Maestro, attraverso opere di “impegno” che incontriamo nuovamente nella sala del camino: la disperata Pietà partigiana, grande olio su tavola del 1954, costruita come un antico compianto sul corpo di Cristo, testimonianza radicale della presa di posizione di Tassi nei riguardi della storia. “Il linguaggio neorealista, figurativo e drammatico ma privo di eccessi espressionisti – scrive in proposito Valeria Tassinari – è rappresentativo del primo periodo di attività dell’artista. Impegnandosi in un soggetto legato alla storia della Resistenza, il giovane pittore avrà certamente potuto trarre viva ispirazione dai racconti ascoltati nelle campagne della sua terra, e dalle voci dei testimoni oculari di quelle tragiche vicende, ancora vive nel dolore”.
Nello stesso ambiente, come a chiudere il cerchio di un’emblematica “elegia” autobiografica e sentimentale, la simbolica serie di papaveri: “il più bel fiore del mondo”, immagine di fragilità, di vita, di colore, di purezza, come dichiarava Tassi in una delle sue tante annotazioni. Il fiore simbolo del partigiano e della sua lotta, qui presente con tre opere a olio (dal 1974 al 2008) in cui, è ancora Valeria Tassinari a scriverlo, “i paesaggi rurali infiammati dal colore dei petali sembrano vibrare di un’energia pura e vitale, per quanto fragile e delicata come l’esistenza umana. L’incanto della campagna estiva si unisce alla vibrazione di quei rossi accesi come vite brucianti di passione, che presto diventano metafore di vite destinate ad essere ardenti e brevi come fiammelle”. Un simbolismo che evidenzia definitivamente “il richiamo all’impegno politico e civile dell’artista”.
Ti imbatti, infine, in Carlo Tassi, quando ti fermi davanti al suo autoritratto, l’ultimo, pochi mesi prima della scomparsa. Non puoi che riflettere in silenzio e ringraziarlo, per la sua arte, per i doni che ha fatto alla sua gente e alla sua terra in tutto l’arco della sua esistenza, e che oggi fa a noi. Per il monito a non dimenticarla, la Storia, in tutte le sue forme e declinazioni e accadimenti umani, a tenere duro, a resistere per sapere ed essere persone vive e consapevoli, nell’oggi e verso il domani delle future generazioni.
E ringrazi Valeria Tassinari, sapiente curatrice della mostra, Mara Vincenzi Tassi, altrettanto sapiente conservatrice e promotrice del lascito del Maestro e il sempre sorprendente Museo della Civiltà Contadina.
“Dal Contado” tutta la rivista, l’articolo di Daniele Seragnoli a pag. 12
